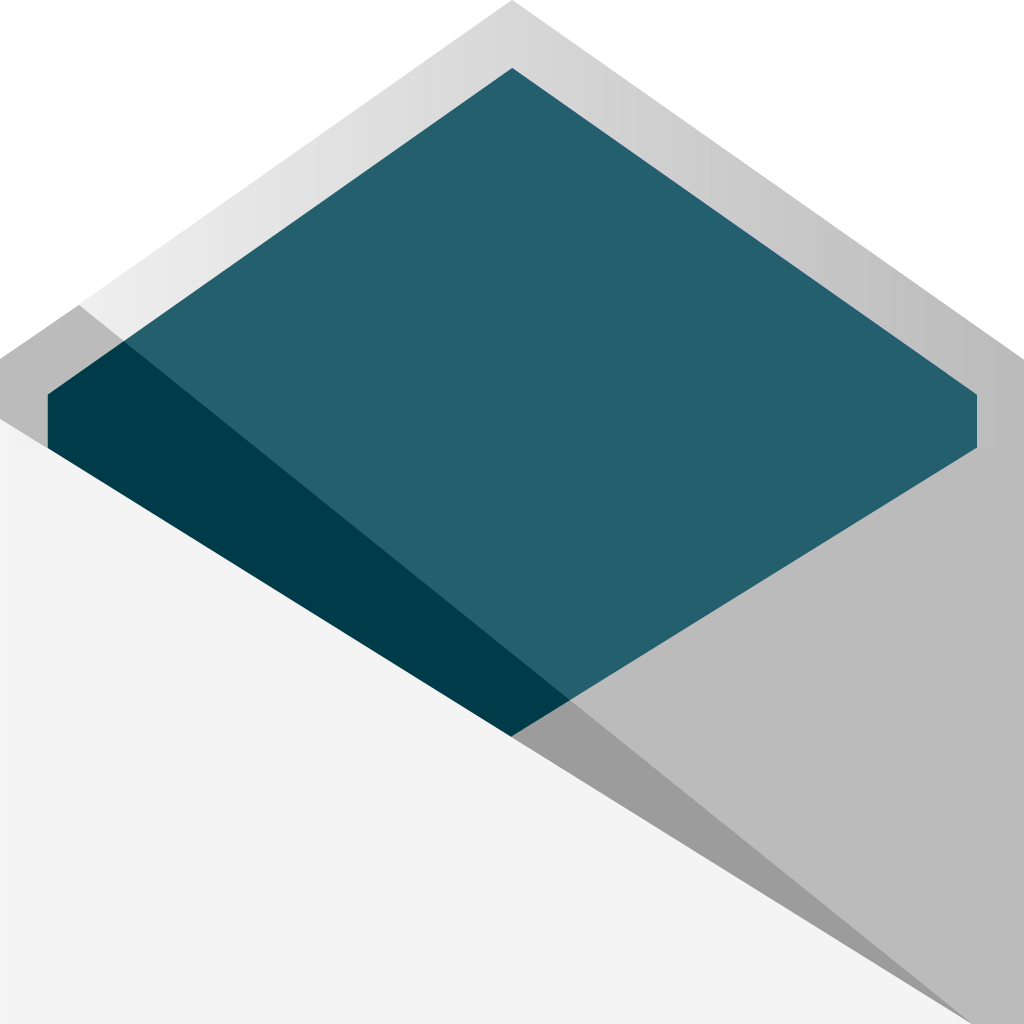Sarebbe curioso scoprire come si posiziona l’employer branding delle 600 aziende coinvolte nell’indagine dell’Associazione dei dirigenti del personale (AIDP) che ha registrato a gennaio il fenomeno della cosiddetta “great resignation” anche in Italia.
L’abbandono volontario di tantissimi giovani di età compresa tra i 26 e i 35 anni ha interessato soprattutto le aree dell’informatica e del digitale, seguite da produzione, marketing e vendite. Il che fa capire che non si tratta di settori tradizionalmente soggetti a un forte turnover come quelli dell’ospitalità o del turismo, ma di comparti che teoricamente dovrebbero riuscire a trattenere i propri talenti più facilmente di altri. Di certo, le organizzazioni che adesso si trovano a dover gestire questa situazione non possono più prescindere da una strategia di employer branding proprio perché devono essere in grado di attrarre quelle risorse venute meno con le dimissioni.
La great resignation, in sostanza, ha fatto emergere che oggi a scegliere non è soltanto il datore di lavoro, ma anche il lavoratore che, alla stessa stregua di quando seleziona un ristorante o un albergo, vuole essere certo che l’azienda che lo accoglierà risponda alle sue aspettative.
Indice degli argomenti
Cosa vuol dire employer branding
L’employer branding è il “marchio” che l’azienda possiede in veste di datore di lavoro. Un marchio riconoscibile tra gli altri per alcuni elementi distintivi così come avviene rispetto al mercato. Per questo, analogamente a quanto accade nelle politiche di marketing rivolte verso la clientela, l’organizzazione deve attuare delle iniziative che ne incrementino la reputazione agli occhi dei potenziali dipendenti. Una prima cartina di tornasole sulla percezione dell’azienda da parte del suo capitale umano si può ottenere mediante le classifiche che ogni anno vengono stilate per definire quale sia il “posto migliore in cui lavorare”. In Italia, quella più nota è fornita da Great Place to Work che suddivide le società in 4 categorie, a seconda del numero dei dipendenti. Le 60 realtà premiate nel 2022 sono state scelte da 94.064 collaboratori attraverso una survey che pesa per il 75% sul punteggio finale. Il modello su cui si basa il questionario si focalizza su 5 dimensioni. Le prime 3 (credibilità, rispetto ed equità) servono a calcolare la fiducia dei dipendenti nei confronti dei manager, mentre le restanti 2 (orgoglio e coesione) mirano a valutare il loro rapporto con i colleghi, con il proprio lavoro e con l’azienda. Senza voler assegnare valore assoluto a questo metodo né ad altri simili, la questione fondamentale da sottolineare è che l’employer branding che si ricava da questa tipologia di ranking può essere misurato. E se lo si può misurare, parafrasando una delle citazioni più ricorrenti di Lord Kelvin, significa che lo si può anche migliorare.
Come migliorare l’employer branding
Il presupposto per migliorare l’employer branding è che l’azienda sia consapevole del suo posizionamento agli occhi dei dipendenti, partendo da parametri oggettivi quali turnover, assenteismo, percentuale di malattia ecc. Accanto a questi indicatori, che hanno carattere oggettivo, vanno raccolti insight interni, ad esempio mediante sondaggi periodici in forma anonima, per esplorare i livelli di engagement e di soddisfazione. Non va dimenticato che i collaboratori sono i primi brand ambassador verso l’esterno e che talvolta i manager o i titolari possono avere un’idea sull’ambiente di lavoro che non collima con quella dei loro dipendenti. Una delle modalità più diffuse per ottenere dei feedback ulteriori è quella di ricorrere a tecniche di sentiment analysis con cui intercettare le opinioni sul brand che circolano su web e social. Pur trattandosi di tecniche di marketing che in genere vengono utilizzate per sapere quale sia awareness e reputation dell’azienda sul mercato, si prestano anche a far tesoro di indicazioni provenienti dai dipendenti attuali e, soprattutto, da quelli che non lavorano più per l’azienda. In pratica, lo sforzo messo in campo ai fini di una customer experience di valore deve essere identico per raggiungere una employee experience positiva, che è il vero pilastro dell’employer branding. Se la customer experience parte dal presupposto che il cliente deve essere sempre al centro, anche l’employee experience non può essere da meno. Con una avvertenza: così come il cliente è il giudice indiscusso dell’esperienza che l’azienda gli sta offrendo, allo stesso modo è il dipendente ad avere l’ultima parola sulla qualità del contesto in cui lavora.

Strategie di employer branding
L’employer branding ha bisogno di dati affinché l’azienda sappia come viene considerata dai suoi lavoratori, tali da far ipotizzare quale possa essere la sua attrattività per le risorse future. Questi dati sono frutto di un’analisi che cerca di fotografare lo status quo, ma non rispondono alla domanda su come effettivamente si concepisca l’organizzazione in quanto datore di lavoro. In altri termini, qual è la strategia che intende porre in atto per distinguersi dai competitor che, a loro volta, desiderano portare a bordo le migliori skill disponibili sul mercato? Non tutte le strategie, infatti, sono uguali. Secondo l’Employer brand research, uno studio condotto da Ranstad su 185 mila persone in 33 Paesi, i criteri più importanti che in Italia guidano la scelta di un datore di lavoro sono i seguenti:
- work-life balance
- atmosfera di lavoro piacevole
- retribuzione & benefit
- sicurezza del posto di lavoro
- visibilità del percorso di carriera
A fronte di questi attributi che i lavoratori ritengono essenziali per indirizzarsi verso un’azienda o l’altra, è interessante notare che nella valutazione del datore di lavoro attuale i dipendenti considerino i primi 3 non soddisfatti. Se sul versante retributivo e dei benefit può apparire ovvio che ci sia una coincidenza di vedute, su quello del buon equilibrio fra vita lavorativa e vita privata, nonché dell’atmosfera di lavoro piacevole, pesano gli anni della pandemia.
Caccia ai talenti
Il Covid-19 ha svelato quanto modelli alternativi come lo smart working possano facilitare il work-life balance e ha dato impulso a priorità diverse rispetto a un equo stipendio. Le organizzazioni, perciò, nell’attuare la propria strategia di employer branding, devono avere in mente su che cosa fare maggiormente leva, anche in funzione del tipo di profilo generazionale a cui si rivolgono. L’indagine di Ranstad ad esempio rivela che mentre i più giovani, cioè la generazione Z, sono alla ricerca di un datore di lavoro che dia valore alla diversità e all’inclusione, i millennial preferiscono un’atmosfera di lavoro piacevole. Sono invece più allettati da retribuzione e benefit gli esponenti della generazione X e da una situazione aziendale finanziariamente solida i boomer. Se queste categorie si calano poi nei settori che oggi in Italia godono delle migliori performance in termini di conoscenza e attrattività, l’ultimo Employer brand research vede collocarsi in vetta i comparti media, automobilistico e quello dei servizi informatici/web. Tutti settori caratterizzati da una forte specializzazione per i quali la caccia ai talenti è complicata spesso dalla carenza di profili con competenze elevate. Da qui la rilevanza dell’employer branding per un recruitment che deve pescare in una platea poco numerosa e fortemente contesa anche da parte di marchi blasonati. Ciò non toglie che l’offerta di una vacancy possa trarre forza da una notorietà conclamata e diffusa sui valori che l’azienda non solo sostiene di perseguire, ma che sono testimoniati da coloro ne hanno fatto direttamente esperienza in quanto lavoratori.